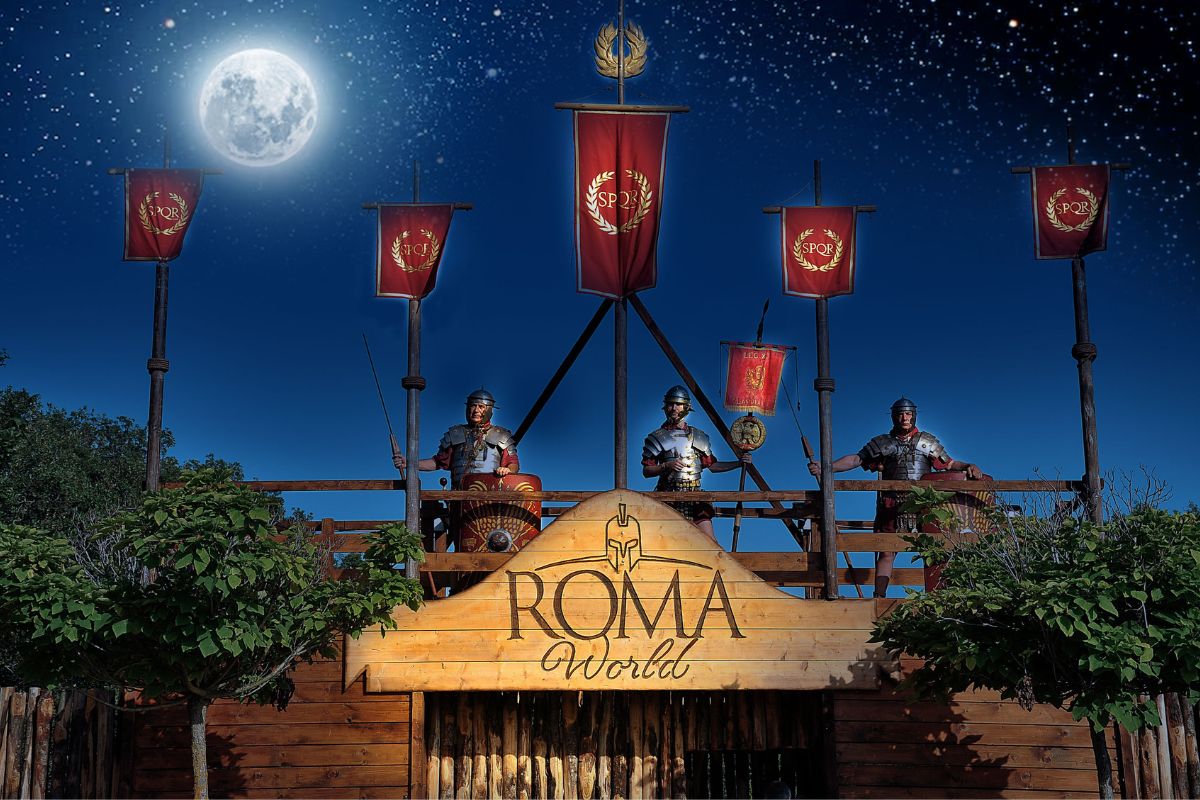C’è un immenso tesoro sommerso sui fondali del mondo, e tra i protagonisti ci sono anche i mari d’Italia. Oltre 202mila relitti sono stati infatti identificati a livello globale, e di questi 1300 sono stati censiti nei fondali italiani.
A dirlo una ricerca sul tema presentata alla recente Bmta, Borsa Mediterranea del turismo archeologico, che si è tenuta a Paestum.
La manifestazione è stata anche l’occasione di presentare la prima edizione del Premio internazionale di archeologia subacquea, intitolato all’archeologo Sebastiano Tusa, scomparso tragicamente a marzo del 2019 in un incidente aereo in Etiopia. Ugo Picarelli, direttore e fondatore della Borsa, ha ricordato la figura di Tusa e il suo progetto non solo di valorizzare i 25 siti di archeologia subacquea della Sicilia, ma anche di promuovere un itinerario culturale europeo “Mediterranean Underwater Cultural Heritage”, da presentare al Consiglio d’Europa. La proposta mette in rete i siti archeologici subacquei di Baia Sommersa e Parco Sommerso di Gaiola (Campania); Isole Egadi, Pantelleria, Plemmirio e Ustica (Sicilia); Egnazia, Isole Tremiti, San Pietro in Bevagna (Puglia); Capo Rizzuto (Calabria); Pavlopetri e Peristera (Grecia); Alessandria d’Egitto (Egitto); Cesarea Marittima (Israele); Kizlan (Turchia).
Secondo la ricerca “Cultura e Archeologia per un turismo sostenibile di qualità. Il caso del turismo archeologico subacqueo e sue implicazioni” a cura di S.R.M. Studi e Ricerche per il Mezzogiorno collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo, il turismo archeologico subacqueo può essere una grande risorsa per l’Italia e per il Mezzogiorno in particolare, incentivando l’arrivo di viaggiatori che prediligono un turismo sostenibile, che coniughi cultura e ambiente, e offra la possibilità di fare un’esperienza in cui si possa “sperimentare e imparare”.
Il Mediterraneo è ricco di reperti archeologici che si trovano nelle profondità marine. A livello mondiale si registrano oltre 202mila relitti, dei quali 15.641 naufragi nel Mediterraneo e 2.854 in Grecia. In Italia, su una mappatura del 50% dei fondali italiani, sono stati censiti oltre 1300 tra siti e relitti sommersi. Un ricco patrimonio per la cui tutela e valorizzazione potrebbero essere impiegati 6,68miliardi di euro (oltre il 2,5% del PNRR), di cui si stima che circa il 36% (2,4 miliardi) sarà destinato alle regioni del Mezzogiorno. Allo stato attuale “manca un sistema integrato e riconosciuto dell’offerta che possa spingere uno sviluppo armonico del settore”, che deve essere incentivato per attrarre i 30milioni di subacquei certificati e per progettare tour subacquei in realtà aumentata, destinati a coloro che, pur restando sulla terra, non vogliono rinunciare ad un tuffo nel mondo sommerso.
Secondo le proiezioni effettuate nella ricerca, basterebbe stimolare appena il 7% degli attuali arrivi turistici culturali nel Paese, che soggiornerebbe almeno un giorno in più per vivere questa esperienza culturale. In questo modo si genererebbe sul territorio un introito aggiuntivo di un miliardo, di cui 200milioni destinati al Mezzogiorno.
E poi ci sono anche le case history nostrane, come quella del Parco Archeo-fluviale di Longola. Il Parco, lungo le sponde del fiume Sarno a cavallo tra le province di Napoli e Salerno, venne alla luce per caso una ventina d’anni fa, durante i lavori per la realizzazione di un depuratore. Si trattava di un insediamento risalente a 3500 anni fa, quindi pre-pompeiano. In 20 anni molto è stato fatto (sono state recuperate 3 piroghe intatte, è stato ricostruito l’impianto dell’originario villaggio sulle palafitte, per esempio), ma molto resta ancora da fare. Piccoli scrigni di tesori poco noti da connettere ai grandi giacimenti di Pompei, Ercolano, Oplonti, Baia, in un circuito virtuoso che tenga all’interno dello stesso perimetro la storia antica della Campania.